Nell’immaginario collettivo, il Santo Graal rappresenta un enigma avvolto nella leggenda, un oggetto di potere mistico e sacro che ha affascinato l’umanità per secoli. Ma cosa si nasconde dietro questo calice? E dove potrebbe trovarsi oggi?
Indice articolo
Nominare il Santo Graal evoca immediatamente leggende e storie misteriose, legate da un lato ai cavalieri della Tavola Rotonda, dall’altra all’esoterismo e tutto un filone di narrativa e cinematografia moderna che si è appropriato in varia misura di questo e altri simboli della cristianità. Perché il Graal è prima di tutto questo, un oggetto che ci ricollega a Gesù, in particolare all’Ultima Cena. Si tratterebbe infatti della coppa in cui Gesù bevve, la coppa che Egli offrì ai Suoi discepoli invitandoli a bere il Suo sangue, nell’istituzione dell’Eucarestia. Nello stesso calice Giuseppe d’Arimatea, l’uomo che raccolse il corpo di Cristo deposto dalla Croce, conservò alcune gocce di sangue stillate dalla ferita inferta dalla lancia di Longino al costato di Gesù.
Diciamo ‘sarebbe’ perché tutto quello che riguarda il Graal è frutto di una leggenda tramandata nei secoli, che nel tempo si è arricchita e ha dato vita a uno dei più affascinanti enigmi della storia.

Gli avvenimenti della Passione di Gesù: dall’Ultima Cena alla Sua crocifissione
La Passione di Gesù è il momento più alto e terribile della Sua…
Il viaggio del Graal attraverso il tempo è un intricato intreccio di mito, religione e letteratura che ha affascinato generazioni di studiosi, scrittori e appassionati di mistero. Sono innumerevoli gli scrittori, i poeti, gli artisti che hanno contribuito all’evolversi di questa tradizione, a partire dalle leggende medievali europee, in particolare dal Ciclo Arturiano. Nelle storie di Re Artù e dei suoi cavalieri della Tavola Rotonda il Graal è riconosciuto come la coppa sacra usata da Gesù durante l’Ultima Cena e successivamente portata in Britannia. In particolare nella raccolta di storie chiamata Ciclo del Graal, scritta principalmente tra il XII e il XIII secolo dai poeti Chrétien de Troyes, Robert de Boron e altri, si parla proprio della ricerca del Graal, simbolo di sacralità e cavalleria, custodito un misterioso guardiano, spesso chiamato il Re Pescatore.
Non esiste un’unica versione della leggenda del Graal. Nel tempo sono state proposte numerose teorie sul significato del Graal, che vanno dalla sua interpretazione come simbolo cristiano della salvezza, alla sua associazione con antichi miti e rituali pagani. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che il Graal possa essere stato ispirato da antichi miti celtici o da oggetti sacri di altre tradizioni religiose. Altri ritengono che il Graal abbia radici storiche e potrebbe essere stato basato su antichi calici o reliquie cristiane, come il Sacro Catino di Genova o il Santo Calice di Valencia. Un’altra tradizione associa il Graal ai Cavalieri Templari, che ne sarebbero stati i custodi per secoli.

Simboli templari: storia e significato di questi simboli antichi
L’Ordine dei Templari non esiste più ma rimane presente nella storia anche grazie ai simboli esoterici templari ad esso legati…
Indipendentemente dalla sua origine, il Graal ha influenzato da sempre la cultura occidentale, ispirando opere letterarie, artistiche e cinematografiche fino ai giorni nostri. La sua natura enigmatica e il suo significato simbolico continuano a stimolare la fantasia e l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo.
La leggenda del Santo Graal
Nelle antiche saghe celtiche e in tutte le tradizioni mitologiche di ogni cultura, esistono racconti che presentano temi simili a quelli associati al Graal. Questi racconti spesso coinvolgono un eroe che intraprende un viaggio avventuroso in un altro mondo, un regno magico o una dimensione parallela alla nostra, dove affronta prove e incontra figure misteriose. Spesso in questi viaggi egli è sostenuto da una coppa o un piatto magico che fornisce cibo inesauribile o possiede poteri curativi, simbolo della natura spirituale o dell’abbondanza divina. Secondo alcuni studiosi il Graal potrebbe essere nato in questo contesto, come oggetto finale della ricerca del significato più profondo della vita, della saggezza e della connessione con il divino. Dunque non solo un oggetto fisico, ma anche e soprattutto un simbolo, carico di significato spirituale e metafisico. La sua ricerca diventa quindi un viaggio interiore alla ricerca della conoscenza, della trasformazione e della realizzazione personale, com’era tipico delle tradizioni celtiche, che spesso esprimevano un profondo legame con la natura, la spiritualità e la saggezza ancestrale.
La parola “gral” o “graal” potrebbe derivare dal latino “gradalis”, che significa semplicemente “vaso”. Tuttavia, dopo la diffusione dei romanzi arturiani, in cui per la prima volta la coppa venne associata a quella utilizzata durante l’Ultima Cena di Gesù Cristo, il significato del termine si è arricchito di nuove sfumature. In particolare “san greal” (“Sacro Graal”) e “sang real” (“sangue reale”). Questi termini francesi hanno generato nuove interpretazioni e significati, e collegato sempre di più il Graal alla sacralità e alla spiritualità, nonché all’idea del sangue di Cristo.
Ma prima ancora rispetto ai romanzi francesi apparvero riferimenti all’ipotetico calice usato da Gesù nell’Ultima Cena in testi italiani, come la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, che nel 1260 raccontava come i Genovesi, durante la prima Crociata, avessero trovato la mitica coppa. Fu proprio un condottiero genovese, Guglielmo Embriaco Testadimaglio, che combatté al fianco di Goffredo di Buglione per liberare Gerusalemme, a recuperare il Sacro Catino, un vaso intagliato in una pietra verde brillante e traslucida ancora oggi conservato al Museo del Tesoro della cattedrale di San Lorenzo a Genova.
Nel romanzo Perceval ou le Conte du Graal, scritto da Chrétien de Troyes nel XII secolo, appare una coppa preziosa, custodita nel castello del Re Pescatore insieme ad altri cimeli sacri. Si tratta ancora di una coppa dell’abbondanza, come quelle presenti negli antichi miti celtici, e non si fa menzione della coppa dell’Ultima Cena. Il Re Pescatore o Re Ferito è stato punito per i suoi peccati passati da una terribile menomazione alle gambe che nessuno può curare. Come conseguenza di questa ferita, la sua terra si è trasformata in un luogo deserto e sterile: la terre guaste. Secondo certe tradizioni le sue gambe sarebbero state ferite dalla Lancia del Destino, ovvero la Lancia di Longino. La leggenda vuole che solo un cavaliere possa salvare il Re Pescatore, ma nessuno ci riesce. Anche Parsifal, l’eroe del romanzo, tenta invano di spezzare l’incanto, senza comprendere che l’unico modo per salvare il Re Pescatore è proprio porgli delle domande riguardo le reliquie che conserva nel suo castello.
Successivamente Robert de Boron scrisse un romanzo dal titolo Giuseppe di Arimatea, nel quale compaiono nuovamente sia il Re Pescatore, sia la coppa misteriosa, il Graal, che qui per la prima volta viene associato al sangue di Cristo. Qui il Re pescatore si chiama Bron, nome che rimanda a Bran, mitico gigante re di Britannia nella mitologia Celtica. Costui è descritto come cognato di Giuseppe di Arimatea, il primo custode del calice in cui Cristo offrì il proprio sangue durante l’Ultima Cena. Si delinea quindi la leggenda di una genia di custodi del calice, che se lo sarebbero tramandato nei secoli proteggendolo.

Altri autori medievali, come Wolfram von Eschenbach, contribuirono alla progressiva cristianizzazione del simbolo del Graal, ma è solo con i romanzi del ciclo arturiano che lo ritroviamo con un ruolo di rilievo, come oggetto della ricerca di molti cavalieri. Alcuni di loro lo trovarono dopo un lungo viaggio, come Parsifal o Galahad, innocenti e puri, mentre altri, come Lancillotto, fallirono e furono in qualche modo maledetti. Anche il Re Pescatore ritorna nel ciclo arturiano, e la ricerca del Santo Graal viene spesso associata al suo nome. La leggenda del Sacro Graal continua a essere tema di narrazioni e studio nei secoli. Nel tempo esso assume connotazioni sempre più precise, diventando una reliquia miracolosa in grado di curare ferite e malattie e rendere immortale chi bevesse da essa.
La narrativa moderna ha rispolverato il mito del Graal, soprattutto dopo l’uscita del saggio Il Santo Graal, scritto da Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln, e pubblicato nel 1982. Secondo questo studio, il Graal sarebbe in realtà la discendenza di Gesù e Maria Maddalena, Sua moglie, approdata in Normandia dopo la Sua morte. Il sangue sacro di Cristo scorrerebbe nei primi re Franchi e il santo Graal non sarebbe una coppa, ma il suo contenuto, il sangue reale dei re francesi.
Alla ricerca del Santo Graal
La questione del luogo in cui si trova il Santo Graal è oggetto di speculazioni, miti e leggende che affondano le radici nella storia, nella letteratura e nella cultura popolare. Tuttavia, non esiste una risposta definitiva o una prova tangibile del suo attuale posizionamento.
Nel romanzo di Wolfram von Eschenbach, il Graal era custodito nel castello segreto di Munsalvaesche, noto anche come Montsalvat, dimora di Titurel, il primo re del Graal. Questo luogo misterioso è descritto come il “monte della salvezza”, un rifugio sacro dove il Graal veniva venerato e protetto.
L’identificazione di Montsalvat con il Monastero di Montserrat in Catalogna è stata suggerita da alcuni studiosi, poiché Montserrat, con la sua atmosfera mistica e la sua posizione isolata su una montagna, sembra rispecchiare l’immaginario del castello del Graal descritto da Wolfram von Eschenbach.
In realtà fin dal Medioevo sono fiorite teorie più o meno fantasiose di dove il Graal sarebbe stato custodito. Arculfo, pellegrino anglo-sassone del VII secolo, raccontò di aver visto e perfino toccato un calice d’argento custodito in un reliquiario vicino a Gerusalemme. Un’altra testimonianza, citata in un romanzo del XIII secolo, colloca il Graal, o una sua copia, a Costantinopoli. Trafugato durante la quarta crociata sarebbe stato portato in Francia, per poi scomparire durante la Rivoluzione francese.

A Genova, nel Museo del tesoro della cattedrale di San Lorenzo, è custodito come abbiamo già detto il Sacro Catino, portato qui dopo la Prima crociata, mentre nella cattedrale di Valencia c’è il santo cáliz, una reliquia misteriosa che re Martino I di Aragona ricevette in dono dal monastero di San Juan de la Peña.
Il legame con la Sacra Sindone
Alcuni studiosi moderni, tra cui lo storico Daniel Scavone, hanno ipotizzato un legame tra il mito del Graal e la Sacra Sindone. Secondo questa teoria, la Sindone, il lenzuolo donato da Giuseppe d’Arimatea che avrebbe avvolto il corpo senza vita di Gesù, sarebbe il vero Graal, in quanto impregnata del Suo sangue. Le notizie relative a questa reliquia si sarebbero poi confuse nei secoli, arricchendosi di dettagli non veritieri, e dando origine alla leggenda della coppa. Secondo Scavone, Giuseppe d’Arimatea non si sarebbe mai recato in Britannia, come vuole la tradizione, ma a Edessa, nell’Alta Mesopotamia, il cui palazzo reale si chiamava Britio, e sarebbe stato il luogo in cui la Sindone venne custodita tra il VI e il X secolo. Dal termine Britio si dedusse erroneamente che Giuseppe si fosse recato in Britannia. Anche questa affascinante teoria richiede ulteriori approfondimenti e ricerche per essere confermata o smentita definitivamente.

La Sacra Sindone: cosa sappiamo fino a oggi
Si dice sia il lenzuolo che ha avvolto il corpo di Cristo dopo la deposizione. Tra fede e scienza…

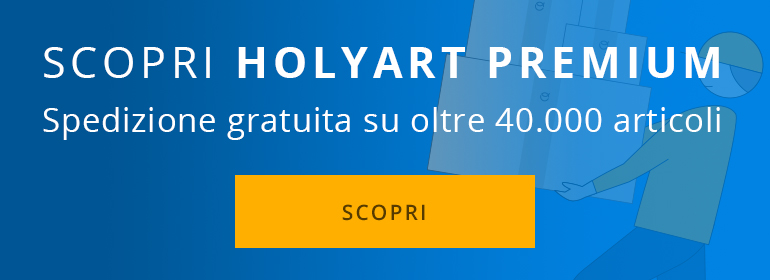









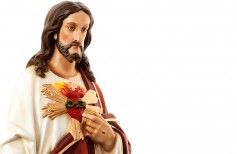




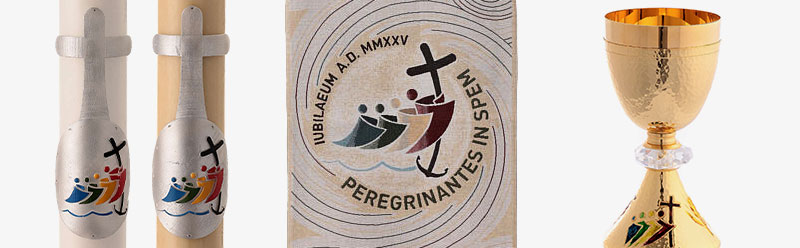




 26 Febbraio 2025
26 Febbraio 2025


