Sacerdote, monaco e frate hanno molto in comune: scopriamo quali sono le differenze fra queste tre figure religiose
Indice articolo
Spesso si tende a confondere tra loro i termini sacerdote, monaco e frate.
Confusione legittima, giacché queste tre figure di religiosi hanno molte cose in comune, e spesso le differenze che li distinguono sono incerte. Senza contare che un monaco o un frate possono tranquillamente essere anche sacerdoti, essendo il ruolo di sacerdote definito dalla possibilità o meno di svolgere il Ministero sacerdotale, appunto, ovvero di essere consacrato per diventare un ministro del culto e avere la facoltà di impartire i sacramenti.
Vediamo di definire meglio queste tre figure.
La figura del Sacerdote
Per la religione cristiana cattolica il Sacerdote è il ministro del culto, la guida spirituale consacrata per proteggere il gregge di Gesù e condurlo alla salvezza. Si tratta di preti, vescovi, e di chiunque, nella gerarchia clericale, abbia ricevuto la chiamata, sia stato consacrato, e abbia scelto di mettere la propria esistenza al servizio della chiesa. Il Sacerdote è colui che può celebrare la messa e impartire i sacramenti, ma è prima di tutto una figura di riferimento, una guida, appunto, come raccomandato da Gesù ai suoi discepoli.

I sette sacramenti della tradizione cristiana
I Sacramenti, e in particolare l’eucaristia, sono considerati l’origine e la massima espressione di tutta la vita cristiana…
Il termine Sacerdote deriva dalla parola latina sacer, ‘sacro’, unita alla radice indoeuropea *dhē- ‘fare’. Dunque anticamente il Sacerdote era colui che ‘fa i riti sacri’, che offre sacrifici alla divinità, che si pone come tramite tra Dio e gli uomini. È un ruolo già presente in tutte le civiltà antiche e nelle religioni del passato, con caratteristiche diverse e nomi diversi. In generale, tuttavia, si trattava di un uomo capace, per vocazione e studio, di pronunciare le parole giuste, le formule o preghiere corrette per parlare con Dio, e insignito da Dio stesso della facoltà di offrire sacrifici a nome del popolo.
Per gli ebrei il Gran Sacerdote era il solo a poter entrare nel Tempio e occuparsi dell’Arca dell’Alleanza. Doveva appartenere alla tribù dei Leviti, che non avevano terra, perché la loro dimora era, appunto, il Tempio. Per gli ebrei il Sacerdote era dunque ancora l’intermediario tra Dio e gli uomini, come per tutte le altre grandi religioni del passato. Questa cosa cambia con la venuta di Gesù. Gesù, morendo in croce per la salvezza di tutti gli uomini, si è reso intermediario tra essi e il Padre, rendendo superflua la figura del Sacerdote come veniva concepito prima di Lui. Il Battesimo rende ciascuno di noi un Sacerdote, investito della facoltà di parlare con Dio, di rivolgersi direttamente a Lui. È il cosiddetto sacerdozio comune, così definito per distinguerlo dal sacerdozio ministeriale, che è quello di cui sono investiti preti, vescovi, e così via. Per la Chiesa cattolica, infatti, può essere considerato Sacerdote (ministeriale) chi abbia ricevuto il secondo o il terzo grado del sacramento dell’Ordine sacro. Il Diacono, quindi, non è un Sacerdote, mentre sono sacerdoti il presbitero (il prete) o il vescovo.

Come diventare diacono: mansioni e formazione
Chi è il diacono e cosa fa? Come diventare diacono? Scopriamo di più su questa figura da sempre presente nella chiesa…
Ma dunque, se noi tutti, in virtù del Battesimo, siamo sacerdoti, a cosa servono i sacerdoti propriamente detti, i preti, i parroci, il vescovo, il Papa? Essi hanno il ruolo che Gesù diede ai suoi discepoli e apostoli, di guide, protettori, pastori di un gregge. Il Sacerdote porta la Parola di Dio tra i fedeli, la spiega e la interpreta nei suoi passaggi più oscuri, e, nel frattempo, consiglia e conforta, incoraggia e blandisce, rimprovera, quando necessario. Il suo ruolo si avvicina a quello di Gesù stesso, capo della Chiesa, Buon Pastore, Fratello tra i fratelli.
La figura del Monaco
La figura del Monaco nasce nell’ambito del primo Medioevo, quando il crollo dell’Impero romano aveva gettato il continente europeo in un’epoca di incertezza e costante pericolo. La furia dei barbari, la perdita dei valori e delle leggi che avevano retto l’Impero più grande e forte che fosse mai esistito, rendevano drammatica la vita di uomini e donne. In questo scenario molti cercarono conforto nella fede, scegliendo di abbracciare uno stile di vita ascetico e solitario, abbandonando il mondo per vivere in grotte impervie, o fitte foreste, o luoghi irraggiungibili, in cui dedicarsi esclusivamente alla preghiera e alla vita contemplativa.
Questa scelta estrema deriva dall’esperienza degli asceti orientali, che cercavano una maggior vicinanza a Dio e la possibilità di elevarsi alla santità proprio tramite l’isolamento totale e un’esistenza improntata agli stenti e alla mortificazione della carne nelle sue forme più estreme. Pensiamo ai Padri del deserto, agli eremiti, o anacoreti, ai cenobiti, che si riunivano in piccoli gruppi e vivevano secondo una regola comune, ma che mantenevano ugualmente l’isolamento spirituale.
Il Monaco del primo Medioevo è dunque colui che vive solo, pregando, soffrendo, ed espiando in questo modo le colpe del mondo intero. Il termine Monaco deriva infatti da monos (solo) e achos (dolore), uniti nella parola greca Monachos. Una vita votata alla sofferenza, dunque, alla penitenza come strumento di redenzione per se stessi, ma soprattutto per tutti i peccatori del mondo. Una connotazione rimasta legata al termine Monaco, che per buona parte del Medioevo continua a indicare uomini che vivono da soli o raccolti in conventi o monasteri, dove si dedicano esclusivamente alla preghiera, alla penitenza e alla vita contemplativa.
Tra il IV e il VIII secolo, tuttavia, la concezione di monachesimo importata in Occidente subirà un’evoluzione.
San Benedetto da Norcia, fondatore dell’ordine religioso più antico d’Occidente, i benedettini, inizia la sua esperienza religiosa come eremita, vivendo per tre anni in solitudine e preghiera in una grotta presso Subiaco. Successivamente, matura il pensiero che chi vuole dedicare la propria vita a Dio possa farlo operando anche in altri modi. A lui dobbiamo la concezione del monachesimo occidentale come siamo abituati a conoscerlo, oltre alla fondazione dell’ordine benedettino e della Basilica di Montecassino, primo esempio di abbazia ‘moderna’ medievale.

I monasteri e le abbazie cambiano faccia. In questi luoghi di lavoro e preghiera i monaci non si dedicheranno più solo alla contemplazione e alla lettura delle Sacre Scritture, ma praticheranno la preghiera comunitaria e occuperanno il tempo il lavoro manuale, per il bene del monastero e della comunità religiosa. Dal momento che spesso questi luoghi di culto erano situati in zone impervie e inaccessibili, era necessario che i monaci imparassero a produrre da soli quanto serviva al loro sostentamento, non solo cibo e bevande prodotti dai monaci, ma anche medicinali e rimedi per la cura del corpo e l’igiene. Ancora oggi ci sono monasteri e abbazie in tutto il mondo che offrono prodotti realizzati dai monaci stessi, o comunque secondo ricette che si tramandano da secoli. Si va dalle marmellate ai funghi secchi, dall’olio e condimenti ai dolci tipici, e poi miele, caramelle, crema al cioccolato, per non menzionare vini, liquori, amari e la birra, che spesso costituiva il solo ‘nutrimento’ concesso ai monaci nei periodi di digiuno, e che ancora oggi è rinomata (basti pensare alla famosa birra trappista). Oltre a questi prodotti alimentari, l’antica tradizione dei monaci ha portato fino a noi rimedi di salute e bellezza, tisane e tonici, creme e impacchi, oli essenziali e medicamentosi, che conservano nel tempo la loro efficacia e il loro fascino immortale.

Ai monaci dobbiamo anche la conservazione e copiatura di testi antichi, che le abili mani degli amanuensi hanno salvato dallo scorrere del tempo, e che artisti miniaturisti hanno arricchito di splendide decorazioni che possiamo ammirare ancora oggi.
La figura del Frate
Anche il termine Frate è di origine medievale, ed è legato alla profonda trasformazione che attraversò la vita religiosa nel tardo Medioevo, dopo la diffusione della Regola di San Benedetto, ma soprattutto con la ‘rivoluzione’ portata da San Francesco. Se già seguendo l’esempio del Santo di Norcia i nuovi religiosi non vivevano più da soli rinchiusi in un eremo, limitandosi a pregare, ma si riunivano in comunità attive e produttive, sia sul piano spirituale, sia su quello materiale, la nascita degli Ordini mendicanti, a partire dal XIII secolo, vide gli uomini di fede uscire dalle mura dei luoghi di preghiera, per scendere nelle strade, mescolarsi con la gente delle città, coi poveri, con gli ammalati, per portare loro conforto e aiuto. La nascita di questo nuovo modo di vivere l’esperienza religiosa è dovuta probabilmente a una risposta della Chiesa cattolica ai movimenti dei catari e dei valdesi, che tanti consensi stavano raccogliendo in Italia e in Francia in quel periodo.

L’esistenza stessa del Frate è un tentativo di imitare l’esperienza di Gesù, vivendo in povertà, castità e ubbidienza, i tre voti che i Frati dovevano abbracciare, traendo la propria sussistenza dall’elemosina e offrendo in cambio aiuto e preghiera. Il primo obbligo che si imponeva a chi volesse diventare Frate, infatti, era il voto di povertà, la rinuncia a ogni proprietà. Anche i conventi in cui i frati si riunivano non possedevano nulla, vivevano solo grazie alla questua, la raccolta di elemosina e le offerte che i fedeli concedevano loro. Una vita semplice, dunque, fatta solo di povertà, preghiera e carità, proprio come si riteneva fosse stata quella di Gesù con i suoi discepoli.
Frate deriva dalla parola latina frater, ‘fratello’, ed è come fratelli che questi religiosi vivevano, in un clima di fratellanza e comunione tra loro e con le persone che aiutavano. I Frati erano caratterizzati, tra le altre cose, da uno stile di vita molto povero e umile, e da un abbigliamento dimesso, con vesti semplici e solo sandali a proteggere i piedi.


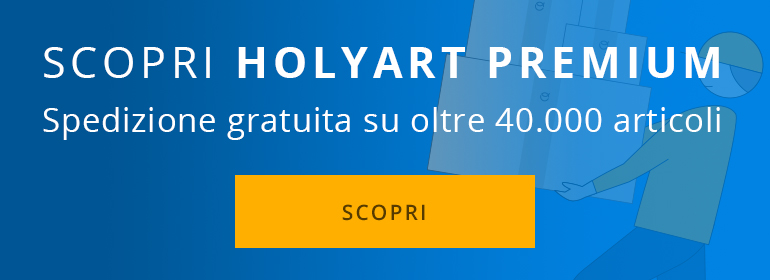














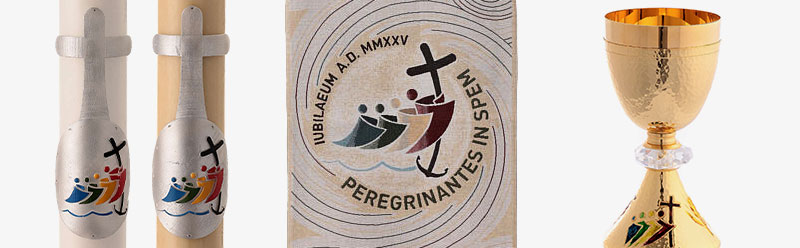




 26 Febbraio 2025
26 Febbraio 2025


